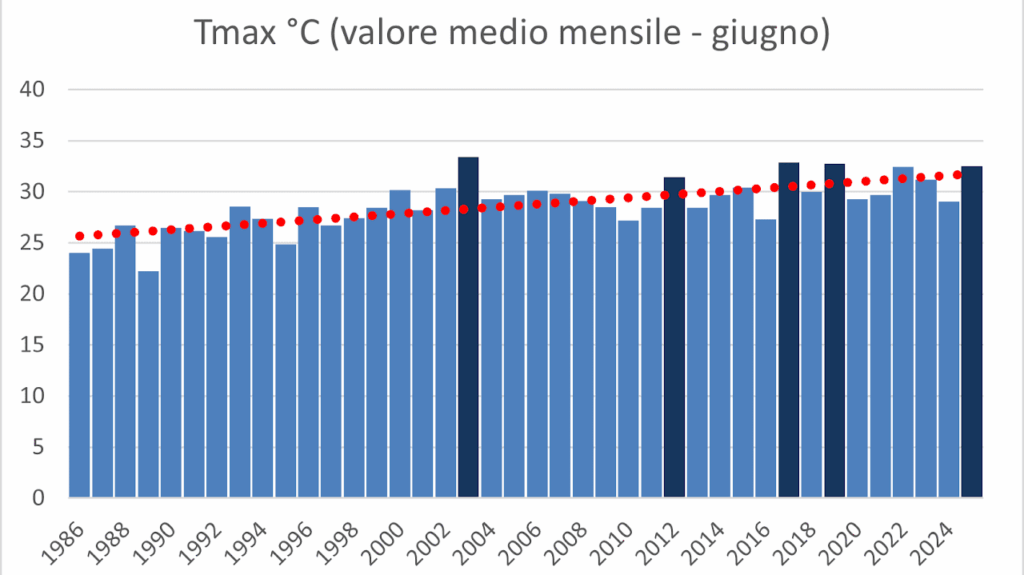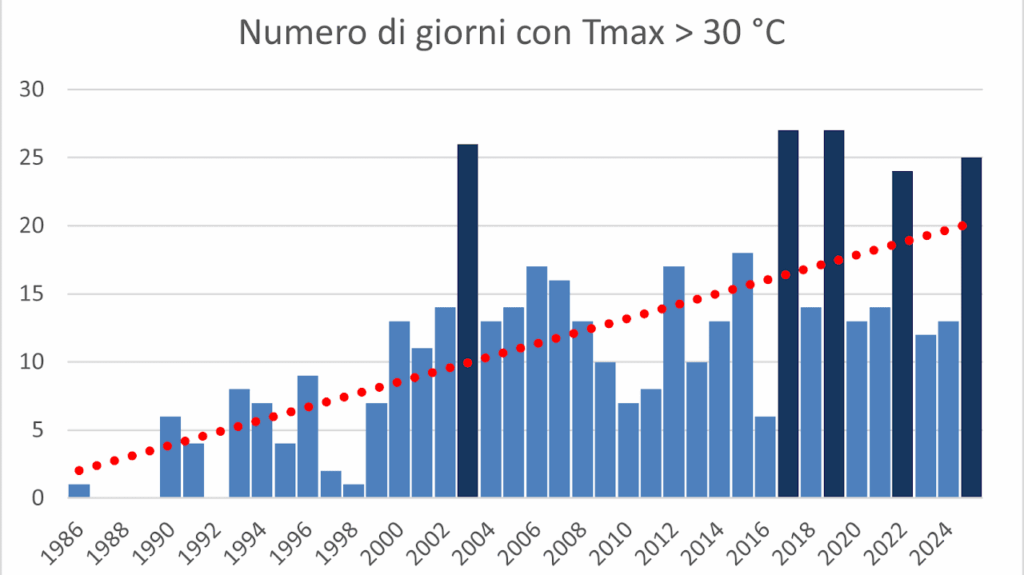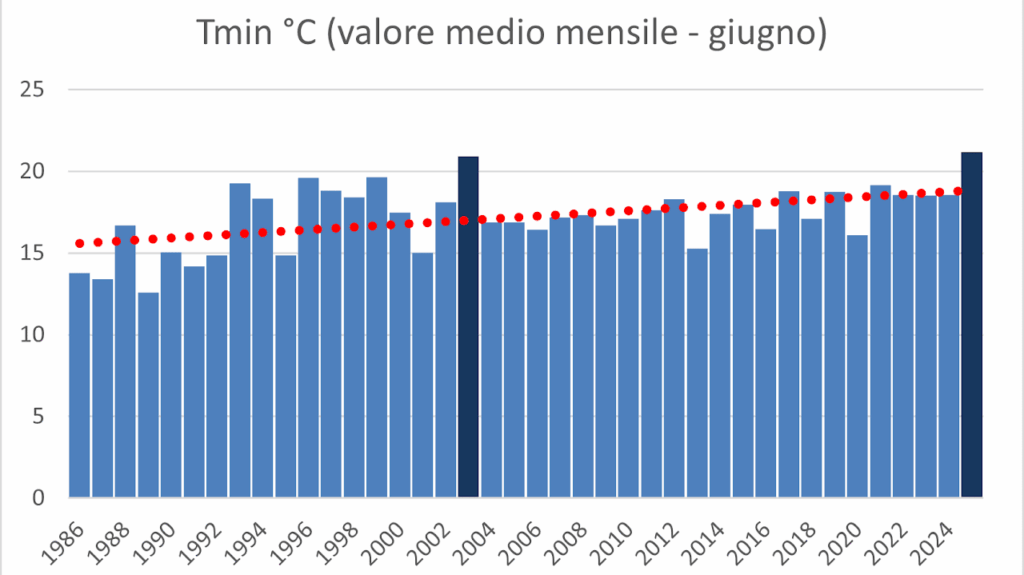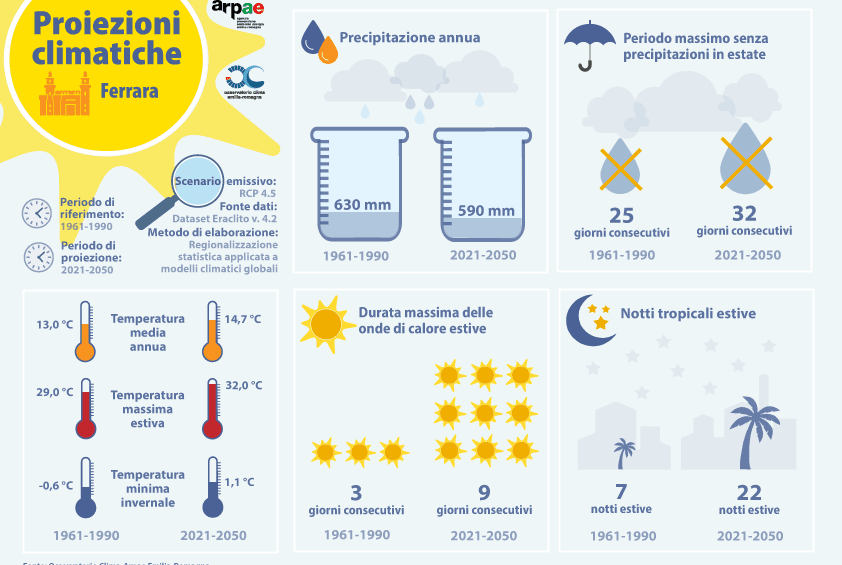L’ineluttabilità del cambiamento climatico e del neoliberismo economico
Non basta e non serve piantare cento miliardi di alberi: se non si cambiano i modelli di sviluppo delle attività umane e delle città che l’Occidente ha imposto al mondo, il verde non è che un palliativo di successo sul piano del marketing.
Come era prevedibile la cappa di calore sta opprimendo l’Italia e gran parte dell’Europa. Sulla stampa si leggono affermazioni di esperti che approfondiscono la situazione proponendo delle soluzioni come il “piantar alberi” che sembra essere quella più immediata. In realtà, non si capisce come questo possa avvenire in questo quadro di immobilità e incapacità di governare le trasformazioni strutturali che stanno riguardando le nostre città. Una immobilità che procrastina continuamente anche la normale manutenzione dei marciapiedi. L’aspetto che colpisce leggendo alcune proposte fornite da importanti esperti è che il cambiamento climatico e il neoliberismo economico sembrano essere fenomeni ineluttabili, certo generati dall’uomo, o meglio dall’umanità, senza che vi siano delle responsabilità precise, insite nei modelli di sviluppo che l’Occidente ha imposto al mondo. Non si possono cambiare le regole dello sviluppo e quindi dobbiamo usare dei palliativi resilienti come il “piantar alberi”: azione la cui importanza nessuno mette in discussione.
Le politiche urbane rappresentano uno dei campi privilegiati della cultura neoliberista, sempre più attraversata da una retorica imperante
Entriamo nel merito di queste prese di posizione “radicali”. Il noto botanico Stefano Mancuso, divenuto ormai una star della forestazione urbana, afferma in un recente articolo che per rinfrescare le città bisogna piantare migliaia di alberi al posto di strade e asfalto, come se fosse una cosa semplice in un paese che continua imperterrito a consumare suolo agricolo per urbanizzazioni. Le strade servono per le auto e i parcheggi e l’Italia è un paese che ha rinunciato da decenni a fare una seria politica per un trasporto pubblico alternativo alle auto e alle strade. In ogni caso, il calore si fa sentire più forte dove vi sono le strade asfaltate, ma queste esistono perché ci sono le case dove le persone vivono e al mattino prendendo l’auto per andare al lavoro, non essendoci alternative praticabili di movimento. Questa affermazione del noto botanico fiorentino appare apolitica, il “male città” sembra essersi prodotto per circostanze non riconducibili a scelte precise di governo, determinate da modelli economici che hanno generato la crisi ambientale che stiamo vivendo. Non c’è nessun accenno alla responsabilità politica ed economica di chi ha governato i processi di trasformazione delle città o delle forze economiche che hanno in questi decenni depredato il pianeta delle sue risorse.
Le politiche urbane rappresentano uno dei campi privilegiati della cultura neoliberista, sempre più attraversata da una retorica imperante che svuota di significato anche le categorie riprese dalla natura (“foresta”, “bosco”, “albero”) per ridurle ad aggettivi subordinati ad interventi che hanno ben altre finalità. Temo che la risposta non possa essere la visionaria Fitopolis di Mancuso, il cui fondamento sembra una banalizzazione di un rapporto complesso tra città e natura. Secondo il botanista, riprendendo i dati del Copernicus Climate Change Service, per risolvere il problema della crisi climatica dobbiamo piantare cento miliardi di alberi. Piantare alberi attorno alle città è una soluzione per ridurre le emissioni climalteranti ma, si afferma, ci sarebbe anche un’altra strada, ridurre tali emissioni intervenendo sul modello di sviluppo ed energetico. Questo avrebbe un profondo impatto sull’economia delle nazioni e richiederebbe un tempo ancora lungo oltre ad un impegno globale, quindi meglio soprassedere e “forestare” le città. In questo modo però si rende ineluttabile il cambiamento climatico generato e poi alimentato, da politiche economiche capitalistiche e neoliberiste che rendono il “piantar alberi” una operazione di greenwashing, perché non incide sui meccanismi e i modello di razionalità che hanno generato uno sviluppo predatorio e produttore di disuguaglianze. Le responsabilità umane che ritroviamo dietro la crisi climatica o si precisano e si contestualizzano economicamente, politicamente e socialmente, o non serve a nulla ribadirle genericamente.
La responsabilità non è di una generica umanità e il problema oggi non è solo “ecologico”, è prima di tutto “socio-ecologico” o “socio-politico-ecologico” ed attiene in maniera diretta all’incidenza delle disuguaglianze nelle dinamiche determinate dalla mutazione climatica. In un altro suo testo, Mancuso sostiene che è la “continua e irrefrenabile necessità di consumare” da parte dell’uomo che sta “profondamente incidendo sulle caratteristiche del pianeta da essere diventato la causa di una delle più terribili estinzioni di massa”. Una responsabilità che associa sia l’uomo del Burundi che l’italiano o l’islandese, ma nel paese africano si emettono 0,07 tCO2 pro-capite per anno mentre in Italia 5,4, quindi le emissioni italiane sono in media cento volte superiori a quelle del Burundi.
Tale interpretazione trasforma la vittima (l’africano) in colpevole, al pari dell’uomo occidentale. In realtà questo modello di sviluppo economico ed energetico che, secondo Mancuso, è troppo complicato da contrastare costituisce il cuore del problema.
Di maggiore complessità è la riflessione di Giuseppe Barbera, professore di colture arboree all’Università di Palermo, quando afferma che gli effetti dell’Antropocene vanno oltre i loro limiti fisici e biologici e coinvolgono aspetti sociopolitici ed economici, i cui effetti li riscontriamo nei conflitti umanitari ovvero nelle guerre e nelle migrazioni climatiche. Secondo Barbera sono necessari “nuovi punti di vista che guardino alla complessità sistemica e non alla semplificazione riduzionista che invece riscontriamo spesso nelle approssimazioni giornalistiche. A tale proposito, nemmeno la distinzione del mondo tra gli “oligarchi” e gli altri, descritta da Mancuso nel quotidiano La Repubblica del 6 luglio, convince. Innanzitutto, perché gli oligarchi non sono una somma di individui ma sono un sistema di potere capitalista e gerarchico, retorico e persuasivo, ormai intrecciato con le forme di governo sia autocratiche che democratiche, che gli “oligarchi” hanno diffuso anche ai livelli intermedi di gestione e di costruzione delle politiche economiche, ambientali e urbanistiche, che arriva anche a determinare o condizionare i nostri bisogni e le scelte quotidiane, spesso senza rendercene conto. Un sistema che dalla pandemia ha virato le sue politiche d’impresa verso le retoriche eco-green-smart per cui, anche su quotidiani di antica tradizione, capita oggi di leggere articoli acritici esaltanti la “rivoluzione verde” sperimentata in città come Neomline in Arabia Saudita o New Cairo entrambe costruite nel deserto sopprimendo (anche con la pena di morte) i diritti delle popolazioni locali, con il concorso della migliore cultura finanziaria, tecnologica e architettonica occidentale. Un oligarca non sta in piedi da solo, necessita di un milieu politico, tecnologico e di un dispositivo comunicativo al suo comando, che lo sostenga divenendo promotore di greenwashing.
In realtà il mondo “umano” (socioculturale e non solo vegetale) è molto più complesso e la convivenza tra uomo e natura ha raggiunto in alcune parti del mondo delle forme di interazioni che forse dovremmo studiare con più attenzione. La cultura della Pachamama a è fondata sul solidarismo cooperativo e sul rispetto della “terra madre” e nella esperienza dei popoli andini Quechua (non a caso diventato un marchio di Decathlon) l’espressione sumak kawsay (buen vivir) si basa sul principio della relazione armoniosa tra essere umano e natura oltre che sull’uso equo, etico e collettivo delle risorse naturali necessarie alla vita della comunità. Una categoria entrata nelle costituzioni di Ecuador e Bolivia. Quindi anche le popolazioni originarie andine e amazzoniche fanno parte di quel “noi umani” a cui imputare la responsabilità della crisi climatica? O vi è una differenza di responsabilità? E che dire delle comunità di pastori africani che, nell’Africa orientale, hanno vissuto per secoli in armonia con il loro ambiente naturale e che oggi sono cacciati dalle loro terre perché governi compiacenti (con l’avvallo di associazioni come il WWF o la Frankfurt Geological Society) con gli interessi occidentali hanno promesso le terre a società finanziare e imprese che devono compensare i crediti di carbonio? Queste, anche piantando alberi, trasformeranno queste aree naturali e rinaturalizzate, in parchi per le eco-vacanze di ricchi occidentali e asiatici rafforzando in questo modo quel “colonialismo verde” inventato dagli europei in Africa fin dalla fine del XIX secolo, come dimostra lo storico francese Guillaume Blanc. Non casualmente queste comunità di umani, che usano i prodotti della foresta per mangiarli e non per venderli, sono tra le più a rischio nel pianeta.
Gli oligarchi non sono una somma di individui ma sono un sistema di potere capitalista e gerarchico, retorico e persuasivo, ormai intrecciato con le forme di governo sia autocratiche che democratiche
La forza mediatica del piantar alberi rischia quindi di generare gigantesche operazioni di greenwashing e la sua forza comunicativa è immediatamente colta, a destra e a sinistra, da amministratori di comuni e di società immobiliari, che se da un lato annunciano gigantesche operazioni di piantumazione e forestazione urbana, che spesso rimangono sulla carta o portano alla moria degli alberi, dall’altro coprono speculazioni immobiliari dove troviamo alberi anche su tetti e terrazze. Non si incide (e non si investe) quindi sui meccanismi di funzionamento delle nostre città e sulla loro “decarbonizzazione” mentre la necessità di elaborare seri piani del verde, da associare ai temi del cambiamento climatico e della biodiversità, rimane di là da venire.
In Fitopolis, si afferma anche che le città del futuro, siano esse costruite ex novo o rinnovate, devono trasformarsi in luoghi dove il rapporto fra piante e animali si riavvicina al “rapporto armonico” (sic!) che troviamo in natura, ma la razionalità occidentale ha sempre esercitato un dominio sulla natura, siamo quindi certi che sia necessario fondare nuove città, non bastano quelle che abbiamo? Le città mal costruite dall’ “uomo”, prevaricanti nei confronti degli alberi e della natura, non sono nate per caso perché sono l’esito di processi culturali e politici che, in particolare dopo la rivoluzione industriale, hanno caratterizzato l’affermazione della cultura del capitalismo e in seguito del neoliberismo. Vi sono, quindi, delle responsabilità che non sono genericamente umane, ma sono associabili a queste specifiche forme di razionalità del pensiero occidentale. Del resto, la cultura occidentale è stata fautrice di una cultura di dominio dell’uomo nei confronti della natura, ma questo atteggiamento non è generalizzabile a tutta la specie umana, le culture indigene, come abbiamo visto, si sono sempre poste come componenti della natura e della foresta, senza ribadire la supremazia della specie umana sulle altre, come ci racconta Ailton Krenak. Al contrario le città nuove e rinnovate, marcatamente neoliberiste e ricche di alberi e vegetazione si basano su processi escludenti e dunque selettivi, determinati dai valori di mercato innescati dalla città rigenerata. Un’azione rigenerativa trova senso solo dentro una politica che sia in grado di gestire socialmente i processi trasformativi, nella prospettiva di garantire a tutti il diritto alla città (che dovrebbe essere un valore non negoziabile). Se non si opera in questa prospettiva il rischio è che le azioni rigenerative siano selettive, perché quando si risana un quartiere popolare i valori immobiliari cambiano e si determinano dei processi di espulsione della popolazione meno abbiente verso le parti più esterne della città che, se non dotate di un efficiente sistema di mobilità pubblica, di servizi alla persona e spazi verdi, determinano, per chi vi abita, condizioni sfavorevoli sia ambientalmente che socialmente.
Quindi, ritornando al punto di partenza di questo testo, quando dalle pagine del quotidiano La Repubblica del 2 luglio scorso, Michele Montano, ordinario milanese di Medicina interna dichiara che è necessario ridurre l’impatto delle ondate di calore, e che in questa prospettiva il “vantaggio può darcelo il verde”, dice una cosa sacrosanta. I vantaggi igienici e salutistici del verde sono qualcosa di cui la cultura urbanistica è consapevole almeno dalla metà dell’Ottocento. Ma quando Montano afferma che i tentativi di abbassare le emissioni di gas serra hanno effetti troppo a lungo termine e non sono sostenibili economicamente, di fatto giustifica questo modello di sviluppo e rende ineluttabile il cambiamento climatico e il modello economico e di potere che lo ha generato. Il “piantar alberi” diventa pertanto una sorta di azione resiliente finalizzata a “restare a galla” in un mondo che non si può cambiare, perché il cambiamento costa troppo.
In realtà, in queste settimane la gran parte dei paesi della NATO, che sono i maggiori responsabili della crisi climatica in corso, si stanno predisponendo per spendere 800 miliardi in Europa per armamenti, in Italia dovremmo spendere tra i 30 e i 40 miliardi all’anno per raggiungere l’obiettivo che la NATO ha dato ai suoi alleati del 5% del PIL entro il 2035. Ma se, come suggerito da Luca Mercalli, questi denari li spendessimo per dare attuazione all’Accordo di Parigi? Del resto, è ormai noto che gli effetti devastanti della crisi climatica sarà a scapito dei più poveri, nel sud del mondo ed anche nell’occidente benestante. La gran parte di popolazione del pianeta non avrà accesso alle eco-smart city che si stanno costruendo nei deserti, nei golfi, o nelle aree metropolitane in via di riqualificazione (ricche di acqua, energia solare, mobilità elettrica, alberi e agricoltura idroponica). Anche in questa selettività si manifesta l’autoritarismo di quel modello economico secondo alcuni troppo difficile da cambiare. Quindi non ci resta che piantare alberi, sperando che non muoiano e aspettare il collasso?
Romeo Farinella
Laureato in Architettura presso lo IUAV, PhD in Urbanistica all’Università di Roma “La Sapienza”, è Professore ordinario di Progettazione urbanistica e Teorie dell’urbanistica all’Università degli Studi di Ferrara.